Giorni fa ho espresso sul mio profilo personale di facebook la mia opinione sui fatti della nave della nave Diciotti.
Quel che penso io conta poco.
Quello di cui parlerò in questo post è del fatto che la mia opinione ha ricevuto due commenti di segno diametralmente opposto, da due persone a cui sono molto affezionata. Ad una di queste, addirittura, ho fatto da testimone al matrimonio e devo ammettere che ad un estraneo che esprimesse un’opinione come la sua, forse non concederei il beneficio del dubbio.
Come si creano i nostri atteggiamenti e che relazione c’è tra le nostre opinioni e il nostro carattere?
Questo tema è affrontato in modo molto intrigante da una branca della psicologia, che si chiama psicologia sociale.
Ovviamente, nel formulare una nostra presa di posizione, concorrono diversi fattori, proverò a dipingere il quadro con un elenco puntato di argomenti, che non sono tutti quelli possibili, ma credo siano sufficienti a spiegare quello che ho scritto al mio amico, cioè che è difficile per ma dare un giudizio su ciò che pensano le persone, perchè ciò che pensano è umano per definizione. Se un pensiero esiste, è umano e ha le sue ragioni di esistere. Se lo condivido o meno è una questione personale.
- La nostra mente tende a dividere gli oggetti del mondo in categorie e sottocategorie, composte da elementi che hanno in comune delle caratteristiche e lo fa perchè se di fronte a un oggetto si dovesse comportare tutte le volte come se fosse la prima volta, perderebbe un mucchio di tempo prima di decidere come comportarsi. Immaginate quanto possa essere stata utile questa caratteristica all’uomo primitivo, di fronte a un predatore: sapendo che un leone ha il pelo, le zanne e ringhia, una volta visto un leone, scapperà non solo da tutti i leoni, ma anche dalla tigre e dal leopardo.
- Nei gruppi umani alcune categorie hanno un valore. Henri Tajfel se ne accorse dapprima chiedendo ad alcuni soggetti di attribuire una dimensione in centimetri prima a delle monete e poi a dei gettoni senza valore di uguale diametro, rilevando che alle monete veniva attribuita, mediamente, una dimensione maggiore, poi cercando di capire se questo fenomeno si verificasse anche riguardo alle categorie sociali, cioè a gruppi di persone accomunate da una o più caratteristiche. Il dibattito scientifico dell’epoca sui gruppi sociali richiederebbe pagine e pagine, quello che scrivo in sintesi è:
- La categorizzazione sociale ci fa percepire il mondo diviso in gruppi, rispetto ai quali o siamo dentro o siamo fuori (uomini, donne, etero e LGBTQ, grassi e magri, italiani e stranieri, disabili e… abili? Mah). Quando sentiamo di appartenere ad una categoria sociale, ci sentiamo vicini ai membri della nostra categoria e molto diversi dai membri dell’altra. Quelli che non appartengono al nostro gruppo (outgroup) ci sembrano tutti uguali ed intercambiabili tra di loro, quelli appartenenti al nostro gruppo invece ci appariranno come non intercambiabili. Ricordate a cosa serve questa caratteristica: è molto utile se ci si deve difendere in gruppo dal pericolo (immaginate i primi gruppi umani che si dovevano difendere dal leone ai primordi del linguaggio), ma cosa succede se questo processo cognitivo umano e ineliminabile chiamato bias intergruppi colpisce intere categorie sociali (i neri per esempio) e a questa categoria sociale si attribuisce un valore? I luoghi più comuni sono: i “cinesi sembrano tutti uguali” (ho una notizia: per loro, anche noi occidentali siamo tutti uguali), “i neri sono tutti uguali e non si sa mai davvero quanti anni abbiano”
- L’identità sociale è quella parte della nostra identità che viene definita dalla nostra appartenenza a delle categorie sociali e condiziona il nostro ruolo nel mondo, la percezione che abbiamo di noi stessi in rapporto agli altri, la percezione che gli altri hanno di noi. Va da sé che esistano identità sociali positive e negative, appartenenze desiderate e indesiderate, confronti, competizioni, tentativi di acquisire identità sociali positive, attraverso la fuga da una categoria (nasco povero e voglio diventare ricco ignorando le mie origini), o cambiando i termini del confronto (sarai anche ricco, ma sei senza cuore) o valorizzando le differenze (grasso è bello)
- Il solo fatto di percepire una categoria di appartenenza e una di non appartenenza, attiva un comportamento di favoritismo nei confronti dei membri del proprio gruppo sociale e un atteggiamento che punta alla massima differenziazione tra gruppi. All’epoca di questi studi Facebook non esisteva, ma fenomeni di questo tipo sono evidenti in qualunque discussione su qualsiasi argomento: alcuni la chiamano “tifoseria”, riconoscendo nelle contese (ad esempio tra chi vaccina i propri figli e chi no, tra chi è a favore degli sbarchi dei migranti sul suolo italiano e chi no, tra chi vota per un partito e chi no) un tentativo non tanto di entrare nel merito delle questioni e scambiarsi idee, quanto quella di cercare la massima differenziazione tra due categorie di pensiero, come se un’opinione definisse un’appartenenza e un tratto distintivo di sé.
- Parallelamente al bisogno di sottolineare la massima differenza possibile tra due gruppi sociali, c’è una tensione all’individuazione, cioè ad evitare di sentirsi fusi con il proprio gruppo di appartenenza, il bisogno di conservare “un senso di unicità del sé”. Questo secondo bias si chiama “auto-favoritismo” e serve a mantenere un’identità positiva non fusa con quella del gruppo di appartenenza, una sorta di egocentrismo.
- Gli esperimenti di Tajfel e quelli successivi avevano messo in evidenza che parallelamente alla strategia cercare la massima differenza tra gruppi, esiste anche una strategia di equità intergruppi. La società include entrambe le tensioni ed esse sono solo apparentemente contraddittorie. Ma come si muovono cooperazione e competizione tra categorie sociali, quando si attiva una e quando l’altra? Dipende probabilmente da molti fattori: la percezione di doversi unire per raggiungere un obiettivo comune oppure quella di competere per le scarse risorse a disposizione. Ci sono intere campagne elettorali gestite più o meno consapevolmente in base a questi principi.
- Quando il mondo appare dicotomizzato, cioè diviso in categorie nette di appartenenza, da una situazione di solidarietà si passa ad una di competizione e più aumenta la percezione di una competizione, più forte diventa anche l’auto-favoritismo, cioè il bisogno di distinguersi dagli altri membri del gruppo. Se pensiamo ai supereroi dei fumetti, ci sono due squadre: i buoni e i cattivi, ma il protagonista è il più forte di tutti. Le narrative nazionaliste sono tutte così.
- Quando cerchiamo di dare una spiegazione e un senso ai comportamenti negativi nostri e altrui, spesso, ma non invariabilmente, spieghiamo i comportamenti degli altri con tratti di personalità stabili (se qualcuno non ci dà la precedenza in strada quando ci spetta è un cretino) e i nostri con le caratteristiche della situazione (se siamo noi a non dare precedenza in strada, abbiamo fretta, sonno ecc non siamo certo cretini). È quella che in psicologia sociale viene chiamata differenza tra attore e osservatore: un conto è quando osserviamo i comportamenti altrui ed esprimiamo giudizi, un conto è quando siamo noi stessi a dover giudicare i nostri comportamenti. Spesso non riusciamo a percepire le contraddizioni degli altri, ma li giudichiamo per le loro opinioni con qualità stabili ed immodificabili.
L’attività principale della mente è quella di attribuire significato e senso a quello che le accade intorno, il come ognuno dà senso a ciò che vive e a ciò a cui assiste dipende in parte da costruzioni individuali e in parte dall’adesione a posizioni socialmente costruite e condivise, ma nel mio modo di vedere (assolutamente non scientifico), distinguere quale sia il contributo dell’individuale e del sociale nella formazione di un’opinione è come voler separare due pezzi di pongo colorato dopo che mio figlio ha iniziato ad impastare. La mia esperienza mi porta a pensare che una posizione politica nei confronti dei migranti non sia tutto quello che c’è da dire sulle qualità di una persona, anche se pensare questo, alle volte mi richiede uno sforzo di volontà. Credo che questi siano tempi di grande insicurezza, con toni più emotivi e più agiti: quando ero piccola negli anni 80 ero una bambina di origini sarde in una regione del nord. Chi mi voleva bene mi diceva che la Sardegna non era sud Italia, come a voler conciliare l’opinione che si aveva della mia persona, con uno stereotipo che andava in tutt’altra direzione. Mi è capitato spesso di fare ironia dicendo che negli anni 90 sono arrivati gli albanesi a chiudere la questione sul mio essere piccola e nera. È un’ironia che ha un suo riscontro scientifico: ci sono studi che dimostrano che c’è sempre una categoria sociale ultima arrivata e i penultimi, quelli discriminati fino al giorno prima, presenteranno le stesse contraddizioni del resto della società: potranno essere solidali o competere come fosse una forma di riscatto, un assimilare sè a una categoria più ampia e più forte, in frasi del tipo “prima gli italiani”, come se fino a poco tempo fa non fossero esistiti i terroni.
In conclusione sì, ho un’opinione. Questo non dice tutto sulla mia persona così come l’opinione opposta del mio amico che si fidò di me al punto di chiedermi di essere testimone al suo matrimonio non dice niente della nostra storia di amici, che hanno attraversato insieme interrogazioni, verifiche, esami, decenni e vicissitudini. Quello che certamente so, conoscendo il mio amico, è che siamo amici perchè ci conosciamo.
Allora forse più che “restiamo umani”, direi “conosciamoci”, ma non nel modo in cui un certo tipo di narrativa politica vorrebbe fare, con un intento pedagogico di una categoria sociale verso un’altra, perchè questo contribuisce a sottolineare altre differenze ancora (per esempio tra sinistra intellettuale e destra vicino al popolo in politica): cerchiamo di capire le ragioni di chi difende un confine e le ragioni di chi lo vorrebbe lasciare aperto, perchè se per un attimo sospendessimo il giudizio, lo sapremmo che nessuno è cattivo, ma ognuno ha i propri guai a cui dà senso e risponde come può.
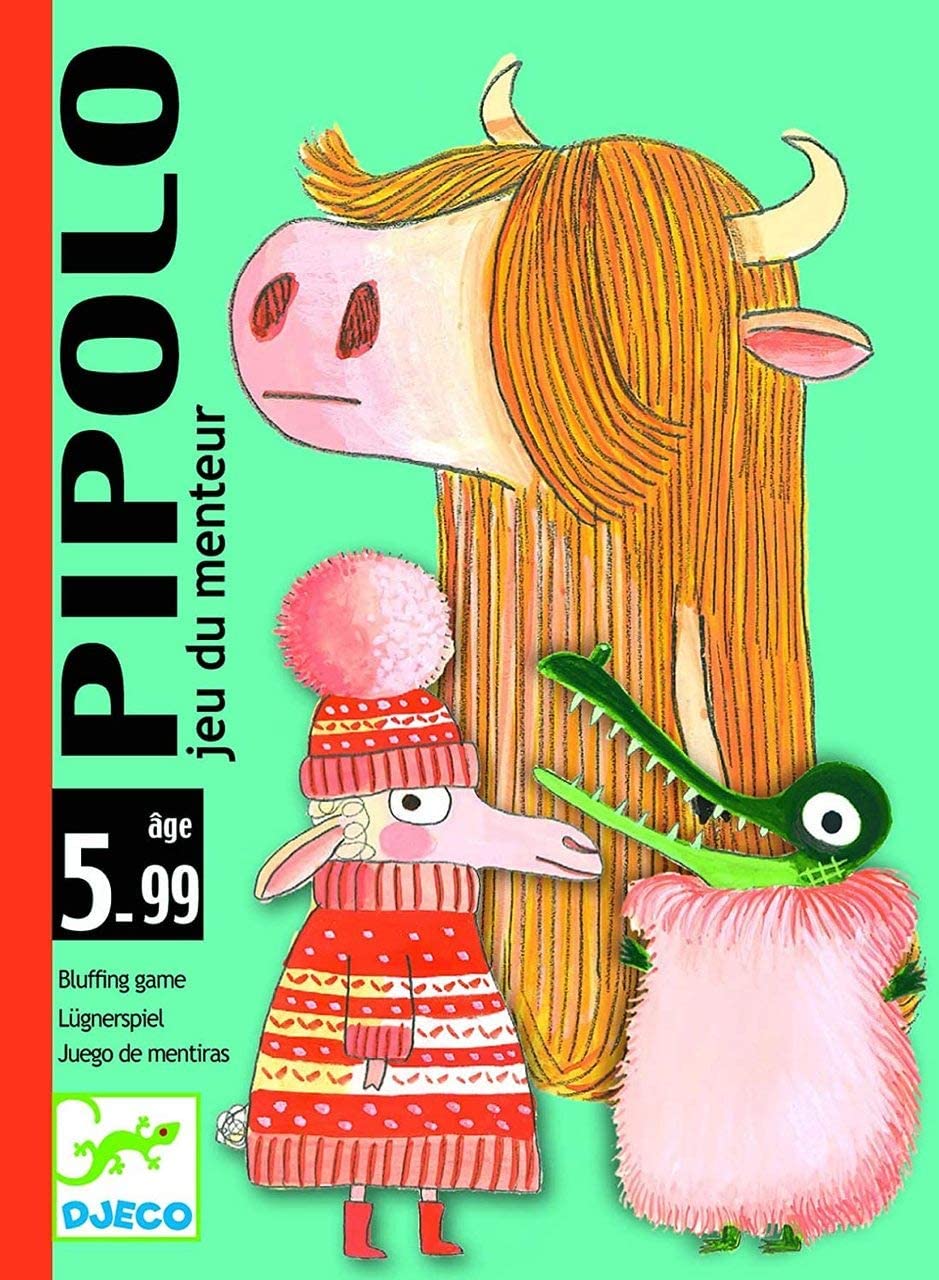


0 commenti